Un romanzo astronomico. Orbital di Samantha Harvey
Booker Prize del 2024, il romanzo Orbital
(NN Editore, 2025) di Samantha Harvey sta ottenendo un certo successo tra
critici e lettori, anche qui in Italia. È un’opera singolare, che segue la vita
quotidiana di sei astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale
(ISS) – quattro uomini e due donne, provenienti da Stati Uniti, Russia, Italia,
Gran Bretagna e Giappone.
Pur avendo l’aspetto esteriore di un
racconto di fantascienza (con tanto di routine spaziali, esperimenti
scientifici e spettacolari vedute della Terra), Orbital si rivela in
realtà un romanzo puramente filosofico e introspettivo. Preciso questo aspetto
perché nelle settimane scorse ho letto dibattiti a dir poco ridicoli, tra chi
si domandava se questa fosse fantascienza (evidentemente persone che il genere
non l’hanno mai frequentato) o meno. Senza nemmeno considerare il fatto che la
stessa Autrice ha dato una definizione della sua opera: «space pastoral», cioè
una storia pastorale spaziale incentrata sulla bellezza del cosmo e pervasa da
una nostalgia per ciò che sta scomparendo. Fine di una storia inutilmente
complicata dai lettori.
Harvey non punta su suspense o trame
avventurose, ma su un registro meditativo capace di suscitare meraviglia e
riflessioni esistenziali nel lettore. La costruzione formale è insolita e
altamente simbolica. Il romanzo è suddiviso in sedici capitoli, corrispondenti
alle sedici orbite complete che la ISS compie attorno alla Terra in un giorno
terrestre di ventiquattro ore. Questa scelta allinea il tempo della narrazione
al ritmo frenetico dell’orbita: nell’arco di una giornata i protagonisti vedono
sedici albe e altrettanti tramonti, e il “giorno” in orbita diventa un concetto
relativo e frammentato. Ne risulta un effetto quasi vertiginoso: il lettore
viene immerso in una percezione alterata del tempo, dove un’alba arriva ogni
novanta minuti e lo spazio sembra fare a pezzi il tempo.
In parallelo alla struttura temporale
ciclica, la narrazione si sviluppa attraverso una prosa ricca, lirica e densa
di immagini. Vi sono forse analogie con Virginia Woolf, perché Harvey
privilegia il flusso di coscienza e le percezioni soggettive dei personaggi,
più che un intreccio lineare e avventuroso. La lettura richiede non tanto
concentrazione, quanto abbandono, e in cambio offre momenti di autentica estasi
letteraria. La voce narrante è mobile e spesso collettiva: sebbene segua i
pensieri di ciascun astronauta, a tratti li fonde in una coscienza unificata,
al punto che i sei individui sembrano formare un unico organismo spirituale. È
una caratteristica che potrebbe ricordare The Waves di Woolf, romanzo in
cui sei personaggi possono essere intesi come frammenti di un’unica identità, e
Harvey stessa ha riconosciuto una somiglianza in tal senso.
Nonostante abbondino le tematiche
filosofiche, Orbital non risulta mai pesante o accademico. D’altra parte
non si tratta di una speculazione filosofica eccessivamente astratta o
elaborata, come in opere (queste sì fantascientifiche) quali Il costruttore di stelle di Stapledon o Solaris di Stanislaw Lem. La narrazione di
Harvey rimane sempre fluida e accessibile, per intenderci. Il tono è
contemplativo e intimista, intriso di sense of wonder, di stupore di
fronte all’immensità dello spazio.
L’uso frequente di metafore serve a
descrivere la Terra vista dall’alto in maniera suggestiva: l’effetto finale è
di una scrittura quasi pittorica, arricchita da riferimenti artistici
(emblematica la digressione sul significato del quadro Las Meninas di
Velazquez, inserita in una retrospettiva di uno dei personaggi). È così che il
romanzo si trasforma in un’esperienza immersiva.
I personaggi sono caratterizzati con pochi
tratti essenziali, sufficienti a distinguerli e a renderli umani, senza
sviluppare complesse sottotrame personali. Anton è il cosmonauta russo di lunga
esperienza; sulla Terra ha una moglie gravemente malata, un pensiero che lo
accompagna in orbita. Roman è il russo più giovane, arrivato a bordo da pochi
mesi come membro aggiunto della missione: il suo ruolo è meno approfondito.
Chie è l’astronauta giapponese dal temperamento riflessivo, che sta elaborando
il recente lutto per la morte della madre. Nell è britannica, riceve notizie da
casa dal fratello e vive con ansia la distanza dalla famiglia. Pietro è
italiano, appassionato di musica jazz (ascolta Duke Ellington mentre si allena
ogni giorno). Shaun è statunitense, e si è aggregato da poco all’equipaggio: è
il più entusiasta e incuriosito dall’esperienza nello spazio.
Benché ciascuno abbia il proprio
retroterra culturale, nell’isolamento orbitale i sei tendono a percepirsi come un’unica
cosa: «C’è qualcosa nello sfrecciare in orbita che li fa pensare in questo
modo, come un’unità, dove l’unità stessa, la loro gigantesca nave spaziale,
diventa viva, diventa parte di loro.» In momenti significativi agiscono in
maniera armonica e l’accento del romanzo è posto più sulla dinamica collettiva
e sull’esperienza condivisa che sulle singole vicende individuali: «L’umanità è
una banda di marinai, sta pensando [Krikalev], una fratellanza di marinai in
giro per gli oceani. L’umanità non è questa o quella nazione, è un insieme,
tutti sempre insieme, qualunque cosa accada.»
Uno dei filoni tematici portanti di Orbital
è la riflessione sul rapporto tra la minuscola condizione umana e l’immensità
dell’universo. Dall’oblò della stazione spaziale, gli astronauti provano un
senso acuto di sublime: si sentono al tempo stesso insignificanti e parte di un
grande disegno interconnesso. La metafora musicale permea spesso le
descrizioni, un aspetto che mi ricorda una lunga tradizione al riguardo, a
partire dalla “cosmogonia musicale” tolkieniana, qui capovolta, come se il
mondo fosse in una perenne formazione: «E la Terra, complessa orchestra di
suoni, banda stonata di seghe e fiati, stralunata distorsione spaziale di
motori a tutto gas, battaglia fra tribù galattiche, eco di trilli da un’umida
mattina tropicale, battute iniziali di una trance elettronica, e in sottofondo
un suono squillante, un suono che si raccoglie in una gola vuota. Un’armonia
incerta che prende forma.»
L’esperienza di stupore vissuta dai
personaggi ricorda il cosiddetto “overview effect” descritto da molti
astronauti reali, quello shock quasi mistico nel vedere la Terra come un
piccolo globo nell’oscurità cosmica. Nel romanzo ciò si traduce in domande sul
nostro posto nell’universo e le reazioni dei personaggi oscillano tra il dubbio
e la meraviglia: vi è chi (Shaun) pensa come si possa, di fronte a quello
scenario, non credere in Dio, e chi (Nell) invece si chiede l’esatto opposto.
Un altro tema chiave è quello del tempo e
di come l’ambiente orbitale ne sconvolga la percezione. Sulla ISS non vale più
il normale ciclo circadiano e Harvey gioca su questa dilatazione. Orbital
ti porta a considerare quesiti all’apparenza banali, per esempio che cosa
significhi davvero “un giorno”: quando lo spazio demolisce il tempo, anche la
mente perde i suoi riferimenti abituali. I personaggi sentono che lo spazio
vuole liberarli dall’idea di giorno e che le ore convenzionali non significano
più nulla se trasformate in sedici micro-giornate di luce e di oscurità.
È una condizione quasi surreale, che
conferisce al romanzo un’atmosfera onirica: vivere in orbita equivale in parte
a vivere fuori dal tempo. Di conseguenza, anche la narrazione assume un
andamento non lineare e fluttuante, mescolando presente e ricordi, momenti di
veglia e di sonno, in modo da rendere il lettore partecipe di questa percezione
alterata.
Il romanzo è anche un omaggio alla Terra.
Harvey celebra l’incanto del nostro pianeta ma al contempo ne evidenzia le
fragilità. Dallo spazio la Terra appare come un gioiello prezioso e gli
astronauti la osservano rapiti, mentre sotto di loro i continenti si toccano,
confondendo i confini nazionali. Questa visione globale risveglia in loro un
forte sentimento ecologista e di appartenenza: notano le ferite del pianeta ma
scelgono la speranza alla disperazione.
A differenza di molte narrazioni cupe
sull’Antropocene, infatti, Orbital non adotta soltanto un tono di
condanna o di pessimismo («Il pianeta è plasmato dall’incredibile forza
dell’avidità dell’uomo […]»), ma mantiene anche approccio più fiducioso verso
le nostre potenzialità positive («Non potremmo vivere in pace gli uni con gli
altri? E con la Terra? Non è un desiderio ardente, ma una supplica
disperata.»). Forse anche ricordando che il pianeta Terra non è da salvare, ma
siamo semmai noi a doverci adattare a esso per poter sopravvivere. Per un
paradosso facile da comprendere, è proprio stando lontani dalla Terra che i
personaggi ne riscoprono il pieno valore. Il messaggio che filtra dalle loro
riflessioni è chiaro: la nostra responsabilità si circoscrive nella cura e
nella custodia, non certo nel controllo («Non hanno nessun potere, solo le
macchine fotografiche e una vista privilegiata e carica d’ansia sulla
magnificenza di quel crescendo. Lo guardano [il tifone] arrivare.»).
Un’altra domanda inevitabile per chi
esplora lo spazio è se vi sia vita là fuori. Nel romanzo il tema viene
affrontato da una prospettiva molto umano-centrica. Si legge delle sonde che
tra migliaia o miliardi di anni raggiungeranno luoghi remotissimi e ci si
domanda se forse qualcuno sarà in grado di interpretare i messaggi e l’arte che
vi avremo depositato.
Il senso di viaggiare nello spazio è
sempre in bilico tra desiderio genuino di scoperta e atto di potenza: «Perché
cercare di vivere dove non si può prosperare, perché cercare di andare dove
l’universo non ti vuole, quando invece c’è un’ottima Terra pronta ad
accoglierti? Non sai mai se questa sete di spazio degli umani sia curiosità o
ingratitudine. Se questo strano desiderio lo renda un eroe o un idiota. Senza
dubbio qualcosa di molto vicino a entrambi.»
Talvolta la visione si allarga all’esterno
della nostra specie, fino ad accorgersi che quello in cui viviamo «è un
universo di margini, che non c’è un centro» e che ogni nostra conoscenza evolve
verso «uno smantellamento dell’ego attraverso gli strumenti dell’indagine
scientifica fino a che quell’ego non sarà ridotto a un edificio in rovina da
cui filtra la luce.»
Così si passa alla visione altra
dall’umanità: «Qualche civiltà aliena potrebbe avvistarli e chiedersi: cosa ci
fanno qui? Perché non vanno da nessuna parte, girano solo su se stesi?» Ma la
risposta riconduce ancora una volta all’umano e al suo rapporto, che pare
inalienabile, con il pianeta d’origine: «La Terra è la risposta a tutte le
domande. La Terra è il volto di un innamoramento felice; la guardano dormire e
svegliarsi e si perdono nelle sue abitudini. La Terra è una madre che aspetta
il ritorno dei suoi figli, pieni di storie, di estasi, di nostalgia. Le loro
ossa sono un po’ meno dense, le loro membra un po’ più sottili. Negli occhi
tante visioni difficili da raccontare.»
Un ultimo insieme di tematiche intreccia
le questioni esistenziali con quelle tecnologiche. Come spiegato, in Orbital
non mancano i grandi interrogativi filosofico-spirituali: tali questioni
rimangono necessariamente aperte, ma il solo fatto che emergano in modo così
centrale dà al romanzo un’aura contemplativa insolita nella narrativa odierna.
In parallelo, vi è una lucida
consapevolezza del progresso tecnologico: gli astronauti notano che forse
verranno sostituiti dai robot e si domandano implicitamente quale sarebbe il
prezzo di questa sostituzione: «Ma cosa significherebbe lanciare nello spazio
delle creazioni che non hanno occhi per vederlo e cuore per temerlo o per
gioirne?»
Il romanzo resta una celebrazione dell’umano e ribadisce che le emozioni, la coscienza e la ricerca di significato definiscono la nostra esperienza nell’universo e la distinguono da qualsiasi altra creatura, naturale o artificiale.
È giunto il momento di tirare le somme.
Per concezione e stile, Orbital si pone all’incrocio tra la tradizione
modernista e la fantascienza filosofica. L’esperimento di Harvey
richiama non solo Woolf, ma anche quel filone di romanzi “di una giornata” dove
l’azione esteriore cede il passo alla vita interiore.
Sul secondo versante, ho già citato Solaris,
opera ambientata su una stazione orbitante dove il vero fulcro non è
l’avventura ma l’analisi dei pensieri e dei ricordi umani di fronte all’oscura
profondità del nostro animo. Come Solaris, anche Orbital adotta
lo scenario cosmico a tal fine, ma Harvey elimina completamente l’elemento
fantascientifico tradizionale, consegnandoci un testo atipico che – a mio
modesto parere – aprirà a un filone di narrativa scientifica vero e proprio
(senza il “fanta”).
Se invece ci rivolgessimo al cinema,
sarebbe inevitabile citare 2001. Odissea nello spazio (1968) di Stanley
Kubrick, che condivide con il romanzo l’ambientazione, l’ambizione filosofica e
il senso di meraviglia, per quanto Harvey rimanga focalizzata, in definitiva,
sulle emozioni umane. Un altro confronto calzante è con Gravity (2013)
di Alfonso Cuaron, ambientato anch’esso in orbita terrestre e incentrato
sull’esperienza solitaria di un’astronauta alla deriva. Gravity traduce
la condizione spaziale in un dramma di sopravvivenza carico di tensione, mentre
Orbital evita volutamente la suspense e l’azione; tuttavia, entrambe le
opere sottolineano come la visione della Terra dall’alto possa trasformare nel
profondo la consapevolezza di sé dei protagonisti.
Orbital è insomma un romanzo inusuale, capace di coniugare rigore intellettuale e sensibilità poetica. Con un tono a metà fra il saggio contemplativo e la narrazione immersiva, è un viaggio attorno alla Terra per rivalutarne l’incanto.
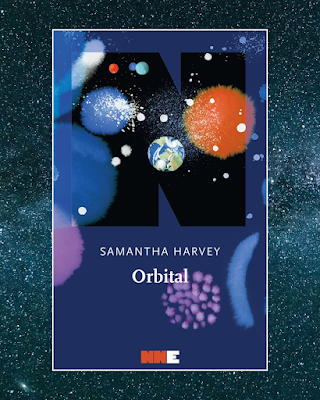



Commenti
Posta un commento
Grazie per aver visitato "La Voce d'Argento"! Condividi il tuo pensiero o lascia un commento: ogni opinione è importante e arricchisce la conversazione. Ti ricordo di rispettare le opinioni altrui e di evitare linguaggi inappropriati: i commenti sono moderati per garantire un ambiente costruttivo e piacevole. Buona lettura e grazie per il tuo contributo!