Robert B. Reich e le deformazioni del sistema
Terzo appuntamento della rubrica Sistema e potere (RSEP), una selezione di saggi, biografie e studi
incentrati sui temi della ricchezza e del potere. Si indaga come le società
odierne li gestiscano nei propri sistemi e come ciò interagisca con la
globalizzazione in senso positivo e negativo.
La rubrica propone ai lettori compendi e
analisi di opere scritte su questi argomenti da parte di economisti, politici, miliardari,
scienziati, sociologi e intellettuali in generale.
L’obiettivo è sensibilizzare le persone
sui pericoli dei cambiamenti climatici, sul crescente divario tra ricchi e
poveri, sulle disuguaglianze alimentate dalla grande finanza. Lo scopo, però, è
anche mostrare alcune possibili soluzioni a questi e altri problemi.
Introduzione
Il post è una sorta di compendio del
saggio Il sistema. Perché non funziona e
come possiamo aggiustarlo di Robert B. Reich, edito in Italia da Fazi
Editore (2021, titolo originale: The System.
Who Rigged It, How We Fix It). Per ulteriori dettagli sui contenuti,
si rimanda alla lettura integrale dell’opera.
Per comprendere in quali condizioni si
trovi il sistema, è necessario rivalutare alcuni concetti che diamo ormai per
scontato. Secondo Reich, bisogna smettere di pensare alla politica come una
competizione tra democratici e repubblicani, tra destra e sinistra: conta il
potere; chi lo detiene e chi lo manipola. Bisogna dimenticarsi l’idea
hollywoodiana di un POTUS che decide in modo unilaterale; dimenticarsi gli
obiettivi economici standard e riflettere invece su chi ne beneficia; non
credere alla fantasia della “responsabilità sociale d’impresa”, da intendere
piuttosto come pubbliche relazioni [p. 17].
Ma i falsi “credi” non finiscono qui per
Reich. Egli sostiene che la battaglia non sia tra capitalismo e socialismo,
poiché la guerra si è già conclusa: regna il socialismo dei super ricchi e il
duro capitalismo per la maggioranza degli americani. È anche sbagliato definire
la competitività nazionale in base alla redditività delle grandi imprese
americane, che in realtà sono ormai globali: la vera competitività risiederebbe
invece nella produttività dei lavoratori, che dipende da istruzione, salute e
infrastrutture [p. 18].
Il sistema è instabile e si muove
secondo spirali virtuose o viziose. Oggi prevale quest’ultima: la meritocrazia
ha lasciato il posto a coloro che beneficiano della ricchezza della propria
famiglia; il reddito della maggioranza dei cittadini non cresce da quarant’anni;
i cambiamenti climatici intensificano la corsa alle risorse. E questi sono solo
alcuni dei principali problemi. Per cambiare, però, bisogna innanzitutto capire
la natura del potere, ovvero «la capacità di dirigere o influenzare il
comportamento degli altri» [p. 19]. L’Autore lamenta il fatto che il discorso
sul potere sia stato trascurato dal dibattito pubblico e accademico, e
soprattutto che non se ne parli nei corsi di finanza e di economia.
Prima
parte
Cerchiamo di approfondire queste
tematiche con lo scritto di Reich, suddiviso in tre parti. La prima si occupa
di un confronto tra democrazia e oligarchia, ripercorrendo la storia
statunitense, in particolare quella degli ultimi quarant’anni.
L’Autore sottolinea un dato. Il potere e
la ricchezza si sono concentrati al vertice, dunque la popolazione in generale
si è indebolita: per questo ha poco significato la tradizionale distinzione tra
destra e sinistra, mentre ha più valore la divisione tra democrazia e
oligarchia. Gli oligarchi esercitano il potere a loro esclusivo beneficio,
adornandolo di promesse, elargendo doni e parlando in termini quali
“responsabilità sociale d’impresa” [p. 25].
L’oligarchia statunitense si è
manifestata in tre ondate. La prima includeva coloro che fondarono gli Stati
Uniti, oligarchi bianchi proprietari di schiavi; la seconda fu quella degli
uomini che fondarono imperi ferroviari, metallurgici, petroliferi, etc., che
subì un duro colpo prima con le leggi antitrust del primo Novecento, poi con
La terza oligarchia nacque intorno al
1980 e ha provocato la crescita della disuguaglianza della ricchezza: per
citare un solo dato, gli economisti Emmanuel Saez e Gabriel Zucman calcolarono
che negli ultimi quarant’anni la quota della ricchezza totale detenuta dallo
0,1 per cento più ricco fosse passata da meno del 10% al 20% [p. 27].
Reich prende come modello
dell’oligarchia Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, a tal punto che il saggio
si possa intendere come una lettera aperta all’uomo d’affari, simbolo delle
cause che deformano il sistema.
Dimon si definisce un patriota, ma
l’Autore cerca di mostrare come questo sia in contraddizione con le sue azioni,
che mirano prima di tutto a massimizzare i profitti di JPMorgan. Il problema –
dice Reich – non è tanto l’ipocrisia, quanto l’influenza della multinazionale e
la capacità di raggirare i politici e l’opinione pubblica [p. 46].
Dimon si dichiara democratico, pur
avendo molte amicizie tra i repubblicani, e negli anni ha più volte discusso di
temi come la povertà, le discriminazioni, le ingiustizie sociali. Egli svolge
attività filantropiche e attraverso JPMorgan si vanta, tra le varie iniziative,
di finanziare progetti di edilizia popolare, prestiti in quartieri a basso e
medio reddito, programmi di formazione per i lavoratori [p. 38]. Piccoli
sforzi, dice Reich: «anche rispetto al reddito netto di JPMorgan, nel 2018
circa cento volte il valore del suo programma di riqualificazione dei
lavoratori» [p. 39]. Non solo: nel 2017, ci fu un taglio delle imposte sulle
società, passate dal 35% al 21% del reddito societario, che portò a un
risparmio di circa 15 miliardi per JPMorgan. I risparmi delle società, anziché
esseri investiti per la società americana, furono utilizzati dalle corporation
per ricomprare le loro azioni. Anche in altri àmbiti vi è la tendenza a
mostrare risultati strepitosi che tuttavia, se ben analizzati, si rivelano una
goccia nell’oceano o uno specchio per le allodole.
Sulla questione razziale, Dimon condanna
la discriminazione e sottolinea gli investimenti di JPMorgan per aiutare le
città più povere, tuttavia, nel gennaio 2017, la multinazionale pagò 55 milioni
di dollari per concludere un’azione legale del Dipartimento di Giustizia, che
l’accusava di discriminare i mutuatari appartenenti a minoranze, con interessi
sui mutui per le case più alti di quelli richiesti ai bianchi, a parità di
profilo creditizio [p. 44].
Sul tema dei cambiamenti climatici,
Dimon si oppose al piano di Trump di uscire dall’Accordo di Parigi, eppure –
nel periodo 2016-2018 –
Nell’agosto 2019,
L’esempio è utile a far comprendere come
i CEO siano restii a sacrificare le azioni della propria azienda e a ridurre i
propri compensi milionari. Non sembra dunque ragionevole pensare che saranno le
stesse aziende a limitare l’attività di lobbying che consente loro di
esercitare la massima influenza. E la dichiarazione della BRT rientra in una
strategia semplice: mettere le mani avanti con una promessa di intenti per
anticipare una legislazione che avrebbe potuto limitare quelle corporation.
Il problema centrale della BRT è di
essere costituita da CEO che hanno svuotato il concetto di leadership della
responsabilità morale, sostituendola con la massimizzazione dei profitti e del
valore per gli azionisti [p. 51].
Reich afferma che esista una forma di
socialismo negli USA: il socialismo per i ricchi. Una grande prova è il
salvataggio finanziario di Wall Street nel
JPMorgan ricevette 25 miliardi dal
governo federale per contrastare la crisi finanziaria che aveva in parte
provocato; Dimon, in quel 2008, fu pagato 20 milioni di dollari. In seguito,
JPMorgan restituì quei soldi, ma continuò a ricevere benefici per il fatto di essere
“troppo grande per fallire”. Infatti, nel 2019 le cinque maggiori banche
americane totalizzavano il 46% di tutti i depositi bancari degli USA [p. 58].
Non solo ricevette denaro pubblico, ma JPMorgan agì contro gli interessi dei
cittadini che aveva danneggiato. Proprio nell’aprile 2008, il Senato respinse
un disegno di legge che consentiva ai giudici fallimentari di modificare i
mutui sulle residenze primarie, per aiutare finanziariamente i proprietari in
difficoltà. Una legge che era stata contrastata dalle banche [p. 60].
A distanza di dieci anni dalla crisi
finanziaria, l’aspetto curioso è che i posti di lavoro persi all’epoca erano
stati più che recuperati, ma il reddito familiare medio, aggiustato
all’inflazione, non era salito, al contrario dei redditi dei più ricchi. La
ricchezza familiare media era di 97.000 dollari nel 2018, contro i 126.000
dollari del 2007 [p. 60].
Le banche non sono le sole a essere
troppo grandi per fallire. Nei primi due anni della presidenza Trump, General
Motors ricevette 600 milioni di dollari in contratti federali e 500 milioni in
sgravi fiscali; nel 2017, la CEO Mary Barra portò a casa 22 milioni di dollari.
Questo non impedì a GM di annunciare, nel 2018, oltre 14.000 licenziamenti, la
chiusura di tre stabilimenti di assemblaggio e di due fabbriche di componenti.
Durante la crisi finanziaria del 2008, i contribuenti l’avevano salvata con un
bailout da 50 miliardi di dollari e i lavoratori erano scesi a compromessi:
nuove assunzioni a metà del salario, indennità pensionistiche ridotte,
assunzione di lavoratori temporanei a salari più bassi, delocalizzazione di
alcuni posti di lavoro. Quando però GM si riprese, non smise di delocalizzare,
né aumentò i salari, da cui lo sciopero del settembre 2019 [pp. 62-63].
Socialismo per i ricchi significa che
l’oligarchia non deve rendere conto. Duro capitalismo per la massa significa
che la maggioranza degli americani è a rischio per eventi sui quali non ha
alcun controllo – come la chiusura delle fabbriche del Midwest o una crisi finanziaria
di Wall Street – e non dispone di reti di protezione in caso di caduta. [p. 68]
Questo dunque il concetto di socialismo
per i ricchi secondo Reich: «è possibile fallire alla grande e tuttavia
ricevere compensi generosi – se siete un CEO» [p. 63]. E cita alcuni esempi:
Richard Smith, CEO di Equifax, ritiratosi nel 2017 con una pensione di 18
milioni di dollari, dopo che una falla nella sicurezza aveva esposto agli
hacker 145 milioni di clienti; Dennis Muilenburg di Boeing, che intascò 23
milioni nel 2018, nonostante le anomalie di due aerei della compagnia, che
avevano provocato due gravi incidenti mortali in pochi mesi; Stephen
Easterbrook di McDonald’s, licenziato nel 2019 a causa di una relazione
inappropriata con una dipendente, che fu liquidato con quasi 42 milioni di
dollari; etc. [pp. 63-64].
Le multinazionali e i loro CEO sono
favoriti dal sistema anche rispetto alle leggi: non solo le condiziona con le
pratiche di lobbying e i finanziamenti milionari a partiti e politici, ma
valutano anche l’entità delle sanzioni rispetto ai guadagni, decidendo spesso
di violare le leggi [p. 67].
Secondo uno studio del 2014 di Martin
Gilens, docente di Princeton, e Benjamin Page, della Northwestern University,
gli interessi dell’americano medio sulle politiche pubbliche hanno un impatto
quasi nullo. I dati che avevano raccolto si riferivano al periodo dal 1981 al
2002: oggi la situazione potrebbe essere di gran lunga peggiorata [p. 69].
Nella prima metà del Novecento, i gruppi
di interessi negli Stati Uniti non erano costituiti solo da banche e
multinazionali: sindacati, cooperative agricole, commercianti al dettaglio e
piccole banche controbilanciavano il potere dei primi (l’economista Kenneth
Galbraith lo chiamò “potere compensativo”) [p. 70].
Negli ultimi quarant’anni la
compensazione è venuta meno: gli americani non dispongono più del tempo e della
fiducia per prendere parte a sindacati e associazioni. Questo si ripercuote
anche sui finanziamenti alla politica: «Tutti i sindacati del Paese spendono, insieme, circa 48 milioni di dollari
l’anno per attività di lobbying a Washington; l’America delle corporation ne
spende 3 miliardi» [p. 71].
Le donazioni miliardarie delle
multinazionali hanno poco a che fare con l’interesse pubblico. Si tratta di
semplici investimenti, destinati a fruttare in modo impensabile: Pfizer, che
nel 2016 donò al GOP 16 milioni di dollari, guadagnò 39 miliardi in risparmi di
imposte; General Electric ne donò 20 e ne risparmiò 16; etc. [p. 72]. La sola
JPMorgan spese, nel solo 2018, 5.960.000 dollari in lobbying, rappresentando
così una delle principali influenze del Congresso [p. 76].
Bisogna tenere conto anche del rapporto
reciproco tra lobbisti e politici, accresciutosi negli ultimi decenni. Per fare
un esempio, diversi ex funzionari dell’amministrazione Obama, che si occuparono
della crisi finanziaria, lavorano oggi a Wall Street: due segretari del Tesoro,
Timothy Geithner e Jack Lew; Peter Orszag, direttore del Bilancio, ora ai
vertici di Citigroup; Mary Schapiro, che fu presidente della Securities and
Exchange Commission [p. 74].
Non stupisce dunque che il Dodd-Frank Act (2010), una legge voluta
da Barack Obama per modificare i meccanismi di regolazione della finanza a
tutela dei consumatori, fu di fatto annacquata attraverso eccezioni ed
esenzioni sollecitate dalle società di Wall Street [p. 76].
Con
la presidenza Trump la situazione si è aggravata. Oltre ai citati sgravi
fiscali, il POTUS riprese un processo di deregolamentazione (deregulation) avviato con Reagan.
Entrambe le iniziative portarono alla crescita del deficit di bilancio del
governo, che costrinse il Tesoro a contrarre, sia nel 2018 che nel 2019,
prestiti per mille miliardi di dollari, che si traducevano in meno soldi
federali per scuola, sanità, istruzione e altri servizi pubblici [p. 89].
Le
imprese americane non si limitano a guadagnare: il problema è che non
distribuiscono ai lavoratori una quota significativa di quei guadagni. I
vertici aziendali statunitensi guadagnano molto più degli omologhi di altri
Paesi ricchi; i lavoratori statunitensi dei ceti medi guadagnano molto meno di
quelli di Canada ed Europa occidentale.
Si
tratta di una questione di sistema politico-economico. Negli Stati Uniti, solo
il 6,4% dei lavoratori privati è sindacalizzato, contro il 37% in Italia, il
67% in Svezia, etc. I Paesi avanzati hanno quasi tutti un sistema parlamentare
multipartitico, che esprime le istanze di diverse categorie; negli Stati Uniti,
il sistema bipartitico sta diventando sempre più limitato [pp. 96-97].
Secondo
Reich, le multinazionali non hanno un legame particolare con l’America, non
sono patriottici. A parlare sono ancora una volta i dati. Nelle cinquecento
maggiori società con sede negli Stati Uniti, il 40% dei dipendenti vive e
lavora fuori dagli USA e un terzo degli azionisti non è americano [p. 99].
Per
le multinazionali, la priorità non è investire nella produttività americana, ma
rispondere agli obblighi verso gli azionisti. Queste imprese non si limitano a
creare posti di lavoro all’estero, ma incentivano la ricerca, lo sviluppo e
l’alta formazione in quei Paesi. Le società americane vengono ammesse in Cina a
patto di condividere le attività di ricerca e di sviluppo. Un caso emblematico
fu il tentativo di Google di realizzare un motore di ricerca per la Cina,
Dragonfly, compatibile con la censura di Stato cinese, e il progetto subì un
arresto solo per l’opposizione dei dipendenti [p. 102].
Nel
regime cinese, pianificatori e imprese statali cinesi sono interessati a far
avanzare la Cina e, dal 1978, l’economia cinese è cresciuta in media oltre il
9% all’anno [103]. Gli Stati Uniti non hanno invece una strategia economica
nazionale per gli investimenti di interesse nazionale.
La
risposta non è certo emulare la Cina, né colpevolizzarla a priori per la
mancanza di miglioramenti significativi nella vita dell’americano medio. Il
punto è che non è possibile prosperare in un sistema gestito da corporation
organizzate per promuovere il benessere degli azionisti e non dei cittadini [p.
105].
Seconda parte
La
seconda parte del saggio spiega nel dettaglio in che modo si sia giunti
all’oligarchia. Ci sono alcuni assunti che sono ormai dati per scontato. Si
crede che il mercato sia neutrale e naturale e che non sia influenzato dalla
distribuzione del potere nel sistema, per cui i cittadini arrivano a
conclusioni come “anche se mi impegnassi nell’attività politica, il sistema non
cambierebbe”. Si crede che se qualcuno guadagni milioni o miliardi se li sia
per forza meritati, facendo sognare ai cittadini medi, un giorno, di poter
aspirare a quel successo. Si crede che se il pianeta sia a rischio, non ci sia
nulla di significativo che si possa fare.
Il
sistema attuale cerca di tenersi in equilibrio, ma il cittadino medio dovrebbe
tentare di uscire dal circolo vizioso che lo porta a perdere diritti, a
lavorare di più che in passato per guadagnare meno, a rassegnarsi allo stato di
cose, pensando che sia normale. I cosiddetti “baroni della rapina” (robber barons) della prima Gilded Age
furono contrastati da politici che non si fecero comprare. Tra questi, John
Sherman, senatore repubblicano dell’Ohio, che promosse le leggi antitrust che
portano il suo nome (Sherman’s Antitrust
Act, 1890). E il governatore e poi senatore del Wisconsin, Robert Marion La
Follette, detto Fighting Bob, che istituì la prima legge sul salario minimo
degli Stati Uniti, o ancora i presidenti Theodore Roosevelt, William Howard
Taft e Woodrow Wilson, che smantellarono i grandi trust [pp. 134-135]. Non solo
politici, ma anche attivisti: suffragette come Susan B. Anthony ottennero il
diritto di voto per le donne; riformatrici come Jane Addams fecero adottare
leggi a tutela dell’infanzia e della salute pubblica [p. 113].
Che
cosa si è interrotto negli ultimi quarant’anni, in questo processo di graduale
(a volte lenta) emancipazione sociale? Reich individua tre cambiamenti
sistemici, che hanno ridistribuito il potere verso l’alto: il passaggio della
governance societaria dal capitalismo degli stakeholder al capitalismo degli
azionisti; il passaggio del potere contrattuale dai grandi sindacati alle mega
corporation; il potere finanziario di Wall Street ormai senza limiti [p. 114].
Nel
secondo dopoguerra, la responsabilità sociale delle aziende non rientrava solo
in un meccanismo velato di pubbliche relazioni. Nel 1951, Frank Abrams,
presidente di Standard Oil of New Jersey, affermò: «Il compito del management è
mantenere un equilibrio giusto e funzionale tra le richieste dei vari gruppi
d’interesse direttamente coinvolti […] gli azionisti, i dipendenti, i clienti e
i cittadini in genere» [p. 118]. I CEO dell’epoca non guadagnavano le cifre
esorbitanti di oggi (circa venti volte la retribuzione dei dipendenti, al
contrario delle trecento volte di oggi); avevano spesso lavorato in prima linea
nelle fabbriche che amministravano; vivevano nelle stesse comunità dei loro
dipendenti [p. 119]. Erano persone cresciute in genere durante la Grande
Depressione e che avevano poi visto le conseguenze della SGM.
Dagli
anni Ottanta, le cose cambiarono. Una nuova generazione di dirigenti, cresciuti
durante il boom economico, cominciò a razziare.
Raider come Michael Milken e Ivan Boesky «presero di mira quelle società che
potevano distribuire utili più alti agli azionisti principalmente abbandonando
gli altri stakeholder» [p. 120]. Tra
questi “altri” c’erano i comuni lavoratori, i sindacati, la comunità. Così
furono abbassati gli stipendi, ci furono licenziamenti, automatizzazioni e
delocalizzazioni. I CEO che si opponevano a questi cambiamenti furono
penalizzati dagli azionisti, su spinta degli scalatori.
Negli
anni Ottanta e Novanta la svolta era avvenuta: i CEO cominciarono ad avere come
unica preoccupazione la massimizzazione del valore degli azionisti [p. 121].
Robert Goizueta, CEO di Coca-Cola, affermò nel 1988 di pensare a «come
costruire il valore degli azionisti da quando mi alzo a quando vado a letto. Ci
penso persino quando mi faccio la barba» [p. 123]. Ad oggi, i predatori
societari vengono chiamati in modo più rispettabile: “azionisti attivisti” e
“gestori di private equity”, chiamati a controllare società poco efficienti [p.
123].
Era
l’ovvia conseguenza di un modo di pensare l’impresa propugnato, secondo Reich,
da figure come il professore di economia Michael Jensen, arrivato alla Harvard
Business School nel 1984. Nei suoi corsi, studi e interventi, egli sosteneva
che le acquisizioni ostili disciplinassero le “imprese inefficienti”, quelle
che a suo dire impiegavano più lavoratori del necessario, pagandoli troppo, e
rimanevano legate a comunità da cui non potevano più trarre il massimo
profitto. Se questo permise agli azionisti e ai dirigenti di arricchirsi,
Jensen non considerò però le conseguenze sui lavoratori e sulle comunità
abbandonate [p. 125].
Oggi
questo modo di pensare è sostenuto dal mito che i dirigenti abbiano un obbligo
fiduciario a massimizzare gli utili degli azionisti. In ciò vi è tuttavia un
errore, ovvero l’idea che gli azionisti siano le uniche parti a investire nelle
aziende e a sopportare il rischio che il valore dei loro investimenti possa
crollare. In definitiva, tutti i cittadini sono stakeholder e partecipano
all’economia del Paese [p. 127].
Il
secondo cambiamento sistemico citato da Reich è una conseguenza del primo.
L’equilibrio di potere tra imprese e lavoratori si è modificato: per ottenere
maggiori profitti, il capitalismo degli azionisti spinse per neutralizzare le
leggi antitrust, rendendo le imprese più grandi e influenti; ridimensionò i
sindacati e depotenziò le leggi sul lavoro, riducendo la quota dei profitti
riservati ai lavoratori. Come conseguenza, le società crebbero, i profitti
aumentarono, ma i salari rimasero fermi [p. 129].
Oggi
i monopoli della Gilded Age sono tornati, ma sottoforma p. es. dei giganti
dell’high-tech. Solo cinque aziende controllano portali e piattaforme chiave:
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Google. Esse acquisiscono ogni possibile
concorrente (così p. es. Facebook con Instagram) e costringono i lavoratori ad
accontentarsi dei salari ricevuti, in quanto spesso non ci sono alternative sul
territorio per quel settore. Vediamo il caso di Amazon, la più ricca
multinazionale americana. Nel 2018 non pagò nessuna imposta federale, ma al
contempo mise all’asta la sede del suo secondo quartier generale, facendo
sborsare miliardi a città e Stati interessati. Fece ritirare a Seattle un piano
per tassare le grandi aziende per provvedere ai bisogni abitativi dei senzatetto
e, come per giustificare questo genere di scelte, donò milioni per progetti di
assistenza agli indigenti [p. 132]. Sembra di rivedere quelle scene di nobili
che nel Settecento donavano pane al popolo affamato, come per auto-compiacersi.
Inoltre, queste iniziative sono un modo efficace di fare relazioni pubbliche, e
risolvono problemi specifici, non intaccando però il sistema che ha dato
origine a quei problemi (per un approfondimento sul modo in cui Jeff Bezos
parla di sé e di Amazon, si veda qui).
La
pressione a ridurre la rappresentanza sindacale non deriva dalla
globalizzazione o dall’automazione. Si tratta di un altro falso mito, poiché
altri Paesi sviluppati (prima ho citato la Svezia) hanno mantenuto alti livelli
di sindacalizzazione e di condizioni di vita dei lavoratori, pur sottoposti
alla stessa concorrenza internazionale. La pressione è provenuta dai predatori
societari. Un esempio è quando, nel 2009, i sindacati non riuscirono a
mobilitare abbastanza voti per una riforma che avrebbe sindacalizzato i posti
di lavoro qualora una maggioranza di dipendenti l’avesse richiesta. Quando fu
presentato il disegno di legge, si presentarono a Capitol Hill centottanta
dirigenti di grandi imprese, per incontrare i senatori indecisi. In Nebraska fu
speso un milione di dollari in pubblicità televisive contro il provvedimento,
per spingere il senatore democratico Ben Nelson a votare no. Ed egli si adeguò
[p. 140].
Il
terzo cambiamento sistemico – la deregolamentazione di Wall Street – deriva dai
primi due. Per comprenderlo, bisogna capire perché i cittadini abbiano
accettato salari stagnanti dal 1980 alla crisi del 2008. La risposta risiede
nei meccanismi di ammortizzamento, che consentirono agli americani di spendere
in modo simile al passato [p. 143].
Il
primo meccanismo di ammortizzamento fu l’ingresso delle donne nel mondo del
lavoro retribuito: molte lo fecero grazie alle nuove leggi contro la
discriminazione di genere, ma in gran parte cominciarono a lavorare per
sostenere il reddito familiare. Il secondo meccanismo fu l’aumento delle ore di
lavoro per persona: crebbero gli straordinari, così come il numero di
lavoratori impiegati in due o tre lavori insieme. Questo portò alla situazione
attuale, in cui gli americani lavorano in media 1.780 ore all’anno, ovvero 70
più dei giapponesi e 424 più dei tedeschi (dieci settimane lavorative e mezza)
[p. 145]. Quando nemmeno i primi due meccanismi furono abbastanza, si giunse al
terzo e ultimo, che sfociò nella crisi del 2008: il prosciugamento dei risparmi
e l’aumento dei prestiti.
Nessun
massimo dirigente delle principali società finanziarie finì in prigione dopo il
2008; furono condannati solo pesci piccoli. La crisi non fu nemmeno sufficiente
a ripristinare il Glass-Steagall Act,
una legge che mirava a separare le banche d’investimento dalle banche ordinarie
[pp. 156-157].
Tra
il 1999 e il 2018, l’economia degli Stati Uniti crebbe del 48%, ma il reddito
per famiglia non crebbe. I più poveri si trovarono con meno ricchezza di prima
della crisi, ma l’1% più ricco aveva raddoppiato la ricchezza di prima; lo 0,1%
l’aveva triplicata [p. 158]. Le tre famiglie più ricche d’America sono oggi i
Walton, dell’impero Walmart, i Mars, dell’omonimo gigante dei dolciumi, e i
Koch, delle Koch Industries, legate al settore energetico: dal 1982, la
ricchezza di queste famiglie è cresciuta di quasi il 6.000%, tenendo conto
dell’inflazione; la famiglia Walmart cresce di 100 milioni al giorno [p. 162].
Negli
USA, non ci sono mai stati così tanti miliardari come oggi. A conclusione della
seconda parte, Reich indica anche le quattro modalità per ottenere un miliardo
di dollari. Un modo è sfruttare un monopolio, come fa Jeff Bezos: l’attività di
Amazon è infatti protetta da brevetti concessi dal governo statunitense. Con
leggi antimonopolistiche, Amazon non otterrebbe tutti quei brevetti e non per
tempi così lunghi [p. 164].
Un
altro modo per fare un miliardo è accedere a informazioni confidenziali non
disponibili ad altri investitori. Un esempio: l’esperto di hedge fund Steven A.
Cohen pagò una multa in seguito a un procedimento penale presentato dal
Dipartimento di Giustizia per l’uso di informazioni confidenziali. Otto tra gli
attuali ed ex dipendenti di Cohen si sono dichiarati colpevoli o sono stati
condannati per lo stesso reato [pp. 164-165].
Un
terzo modo è pagare i politici. Charles e David Koch, insieme ai loro gruppi,
spesero una ventina di milioni di dollari in lobbying a favore degli sgravi
fiscali di Trump, comprese le donazioni ad alcuni politici. L’investimento
fruttò loro più di un miliardo di dollari all’anno [p. 165].
Un
quarto modo per diventare miliardari è ricevere i soldi da genitori o parenti
ricchi. Circa il 60% di tutta la ricchezza familiare d’America viene ereditata:
negli USA, i guadagni in conto capitale di una generazione sono cancellati
quando le attività vengono trasferite alla generazione successiva e, inoltre,
l’imposta di successione è molto limitata. Questo ha dato vita a
quell’aristocrazia che non ha mai lavorato in vita propria e che si è
arricchita ulteriormente in questi decenni [pp. 165-166].
Globalizzazione,
cambiamenti tecnologici, ricerca di uno stile di vita al di sopra dei propri
mezzi, ridotta istruzione e produttività: queste sono alcune questioni reali
del presente, ma che troppo spesso vengono additate come il vero problema. La realtà è che il
lavoratore medio ha perso potere contrattuale per poter ricevere una parte
rilevante dei guadagni dell’economia. La risposta al problema si trova nella
politica e nel riequilibrio tra ricchezza e potere nella società [pp. 170-171].
Terza parte
La terza e
ultima parte del saggio si concentra sui meccanismi con cui sconfiggere
l’oligarchia e ristabilire un’autentica democrazia.
Innanzitutto
bisogna prendere coscienza della rabbia e della frustrazione delle persone,
sfruttata da politici opportunisti che impiegano una retorica razziale e di
genere a fini elettorali e per preservare il potere attraverso le divisioni. La
furia anti-establishment, sottesa alle tensioni razziali, portò p. es. Donald
Trump a vincere le elezioni del 2016 [p. 184].
Secondo Reich,
una prima soluzione potrebbe riguardare i democratici: il partito dovrebbe
riconquistare i voti della working class, in una coalizione interraziale che
includa operai, ceti medi e poveri. Per farlo, però, dovrebbero abbandonare in
modo netto l’attenzione per gli elettori indecisi suburbani ad alto reddito,
nonché la dipendenza dalle grandi imprese (l’intreccio con esse fu uno dei
motivi per cui molti elettori si rifiutarono di votare Hillary Clinton) [p. 187].
Un’altra
soluzione risiede nell’accesso all’istruzione di alto livello. Il problema è
evidente: nel 2019, il Dipartimento di Giustizia incriminò decine di ricchi
genitori per aver sfruttato regalie e frodi per l’ammissione dei propri figli
ai college d’élite [p. 192]. L’ulteriore dato allarmante è la disparità di
trattamento giuridico, in base al reddito, per chi compie questi reati. Un solo
esempio: nel 2019, l’attrice Felicity Huffman fu condannata a quattordici
giorni di carcere per aver pagato 15.000 dollari per aggiustare il punteggio
SAT di sua figlia, affinché potesse entrare in un’università prestigiosa. Nel
2011, Tanya McDowell, una madre nera senzatetto di Bridgeport, in Connecticut,
fu condannata a cinque anni per aver iscritto il figlio di cinque anni a una
vicina scuola pubblica [p. 195].
Le oligarchie
mantengono il potere in tre modi: attraverso i sistemi di credo (religioni,
dogmi, ideologie); le regalie alle persone più influenti per averne il
sostegno; le minacce inventate o presunte (nemici stranieri e interni) [p.
189].
Il moderno
equivalente del diritto divino dei re potrebbe essere chiamato “fondamentalismo
di mercato”: la tesi è che se il libero mercato ha portato al vertice alcune
persone, questa loro ricchezza debba essere giusta, naturale e inevitabile [p.
190].
Le oligarchie
sostengono inoltre le cause più svariate, spesso le più progressiste.
Elargiscono donazioni e avviano programmi per la sostenibilità ambientale, per
l’istruzione dei poveri, per contrastare le disuguaglianze sociali, ma – ancora
una volta – sotto questo velo milionario di donazioni si celano interessi
aziendali. Per fare due esempi, ci sono oligarchi che finanziano in
contemporanea democratici e repubblicani, o che fanno donazioni in difesa
dell’ambiente e che al contempo avviano progetti per nuove trivellazioni.
Bisogna dunque
essere consapevoli di questa ambiguità e guardare con ragionevole ottimismo al
futuro. Guardando ai dati, la maggioranza di chi ha meno di diciotto anni,
negli Stati Uniti, è composta da ispanici, asiatici, abitanti originari del
Pacifico, afroamericani, bi- o multirazziali. Inoltre, la maggioranza degli
studenti universitari sono donne. Ora, alle elezioni del 2018 votarono
moltissimi giovani e il loro attivismo, legato a diversi temi dell’attualità, è
destinato ad avere un peso crescente nella società americana [p. 209]. Medicare
for All, Green New Deal, una tassa sulle grandi ricchezze per finanziare questi
progetti, etc.: le idee non mancano, ma per realizzarle c’è bisogno di una
redistribuzione del potere [210].
Pur consapevoli
del divario tra ricchi e poveri, la sola coscienza di classe non riuscirà a far
superare le profonde divisioni culturali, storiche e d’identità, alimentate da
demagoghi che cercano di mettere contro afroamericani e ispanici, coltivano la
paura come deterrente all’azione collettiva, etc. [p. 215].
È
necessario riscoprire che cosa significhi essere un cittadino con
responsabilità verso il bene collettivo. Può anche significare una svolta
rispetto al sistema bipartitico: nel 2018, per il 57% degli statunitensi era
necessario un terzo grande partito; in un sondaggio del 2017, il 70% dei
giovani voleva un terzo partito [p. 216].
Oltre alla
rappresentanza, c’è bisogno di riforme, che partano dall’applicazione di leggi
antitrust, che smembrino le quattro grandi banche di Wall Street e i cinque
giganti dell’high-tech, o perlomeno che la proprietà intellettuale di
quest’ultimi sia resa accessibile a concorrenti più piccoli [p. 221].
La
terza parte è, purtroppo, la più idealista. Pur fondandosi su alcuni dati di studi
e di sondaggi, questa parte si affida soprattutto ad analoghi esempi nella
storia americana, nella speranza che essi rappresentino una fonte di
ispirazione per il presente. L’invito alla partecipazione dei cittadini alla
vita politica è ormai un topos di questo genere di saggi, che ritroviamo anche
negli ultimi libri di persone influenti come Bill Gates (qui) o Al Gore. La
conclusione è rivolta direttamente a Jamie Dimon. L’intento del libro è di
sollecitare un cambiamento del sistema in modo pacifico e democratico, ma,
leggendo i dati e i fatti riportati nel testo, viene da chiedersi se, forse,
non siamo alle soglie di una nuova guerra civile, o di una rivoluzione
epocale.
Nota: per il precedente episodio della rubrica, si veda qui. Si tratta di un approfondimento sul pensiero di un miliardario dei nostri tempi, Jeff Bezos.
Per il successivo episodio della rubrica, si veda qui.
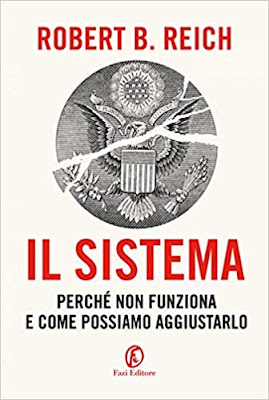



Commenti
Posta un commento
Grazie per aver visitato "La Voce d'Argento"! Condividi il tuo pensiero o lascia un commento: ogni opinione è importante e arricchisce la conversazione. Ti ricordo di rispettare le opinioni altrui e di evitare linguaggi inappropriati: i commenti sono moderati per garantire un ambiente costruttivo e piacevole. Buona lettura e grazie per il tuo contributo!