Arte e scienza. La trasmissione del sapere e il mito deleterio dell’evoluzione
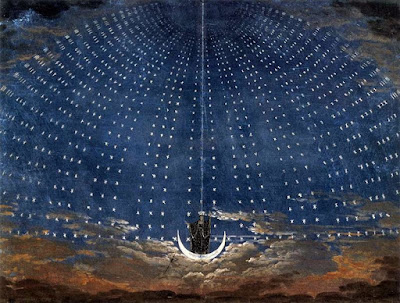 |
| K. F. Schinkel, Salone delle Stelle nel palazzo della Regina della Notte (1815) |
Ѐ un’opinione
molto diffusa ai nostri tempi quella che sostiene che nell’arte non ci siano
più idee, poiché sarebbero già state tutte realizzate. Con il termine “arte” si
intende evidentemente non solo l’arte in senso stretto, ma in generale la
letteratura, la cinematografia, la musica e qualunque altro prodotto della
mente umana a cui viene comunemente attribuito un valore artistico.
Ora, questa
impressione ha origini piuttosto antiche e, per esempio, già alcuni pensatori
dell’antica Roma ritenevano che il patrimonio greco avesse fornito all’umanità
una base per lo più insuperabile, in particolare a livello artistico. Non a
caso, il maggior pregio della cultura romana si esplicò senza dubbio nel
diritto, per non parlare dell’alto livello ingegneristico di cui ancora oggi
possiamo vedere le tracce. Certo, non tutti nell’antichità romana erano a tal
punto filo-ellenici, tanto che l’arte romana sviluppò una propria via e segnò un
notevole sviluppo soprattutto in àmbito architettonico. E tra coloro che “portarono
avanti” l’arte non mancarono nemmeno personaggi che quel magnifico (spesso
ideale) mondo greco lo apprezzavano e ne erano anzi profondamente influenzati.
Quest’ultimo
punto mette in evidenza un elemento importante: l’arte che ci ha preceduti non
solo condiziona la nostra realtà artistica (sia che la si approvi, sia che vi
ci si opponga), ma attraverso l’arte che il presente produce, il passato può
essere trasmesso.
Oggi siamo
abituati a pensare alla conservazione del sapere attraverso il mezzo per
eccellenza, il libro: prima della stampa vi erano gli amanuensi e oltre e prima
della carta altri supporti, dalla pergamena, al papiro, persino alla pietra.
Tuttavia, prima ancora che questo genere di trasmissione scritta prendesse il
sopravvento, la trasmissione avveniva in forma orale: poteva trattarsi della
trasmissione di un sapere tecnico all’interno di una famiglia; di un modo per
legittimare una proprietà sulla base di una consuetudine di cui tutti erano
partecipi; poteva infine trattarsi della trasmissione di saperi di ordine
spirituale. Tutto ciò proseguì anche con la diffusione della scrittura, ma a
poco a poco perse quasi ogni valore, in particolare proprio nel contesto spirituale.
Questa
concezione si affermò largamente con l’invenzione della stampa e con la
rivoluzione scientifica del Seicento, che determinò la validità di una data
conoscenza solamente quando questa poteva fornire prove (dunque fonti, perlopiù
scritte) della sua veridicità. Qualcosa di simile era già accaduto, per
esempio, nell’Alto Medioevo, quando molti monasteri, a causa del clima politico
incerto, si premurarono di individuare (cioè spesso “creare di sana pianta”)
atti di fondazione o di cessione che attestavano appunto un antico diritto a
possedere quella determinata proprietà. E qualcosa di simile si ritrova anche
nella celebre Donazione di Costantino,
riconosciuta quale falso solo a secoli di distanza dalla sua creazione.
Dunque la
scrittura ci mise millenni ad affermarsi come mezzo di conservazione e
trasmissione del sapere, ma alla fine ebbe la meglio. Nel Settecento ci fu un
ulteriore sviluppo. Sull’onda di una ricerca di tipo enciclopedico, che ormai
si apriva non più alla sola Europa, ma al resto del mondo, il modello di sapere
che si affermò doveva tenere conto delle fonti, saperle indagare in forma
critica, escludendo tutto ciò che in maniera piuttosto vaga e generalizzante fu
definito “superstizione”.
Ѐ bene precisare
subito che molto dell’eredità culturale e sociale dei millenni precedenti, che
ancora sopravviveva, era a tutti gli effetti una superstizione, questo se non
altro nell’ottica del metodo scientifico. Vi era però in quel sapere una
memoria più antica, forse ormai inutilizzabile, forse tramandata in modo errato
nei millenni, che però non poteva ridursi a banale superstizione.
Fortunatamente, gli eccessi dell’età dei Lumi (fondamentale per la coscienza
dell’umanità, ma comunque non scevra da eccessi) furono ridimensionati dalla
nascita di poco successiva di una coscienza di ordine meno razionale e più
sentimentale. Il Romanticismo, tra quest’ultime correnti, ebbe il pregio di
rivalutare il Medioevo, la spiritualità e il sentimento umano, in un efficace
contrappeso al razionalismo che, isolato e chiuso in se stesso, rischiava di
sfociare in una fede tanto cieca quanto antiscientifica.
In prospettiva,
dunque, questi due poli si confrontarono e si scontrarono, ma è evidente che
risposero a due necessità espressive dell’essere umano. E la trasmissione del
sapere? Proseguì in àmbito scientifico, basandosi su un metodo ormai consolidato,
e in àmbito umanistico, fondandosi tanto sulla fonte scritta quanto sulla fonte
orale. Il pregio di quest’ultima ricerca era ed è quello di poter affondare le
mani alle origini del mondo, ma questo – è evidente – rappresenta anche il rischio
maggiore. D’altra parte, la ricerca scientifica talvolta ha scoperto e scopre
alternative ad un sapere tradizionale, così come – e non è raro – conferma
saperi piuttosto antichi, pur adattandoli al proprio linguaggio e alla propria
percezione della realtà (curiose sono le analogie tra tradizione e scoperta
scientifica di cui gli scienziati ignorano l’esistenza).
Ma, all’inizio
di questo testo, ricordavamo come sia un’opinione comune che nell’arte – e a
questo punto diremmo anche nella scienza – non sembri più possibile creare
qualcosa di nuovo. Nel contesto scientifico questo è da escludere, almeno in
parte. Soprattutto negli ultimi due secoli, la scienza ha avuto uno sviluppo
tale da essere diventata in molti campi di studio piuttosto specialistica e di
difficile comprensione all’esterno. Una persona comune ha in mente figure come
Newton, Einstein, Hawking e pochi altri: fanno parte dell’immaginario collettivo,
ma nello specifico sono molto poche le persone che hanno studiato, compreso ed
elaborato i loro studi. Non è in effetti cosa da tutti poter affrontare
argomenti che prevedano formule, calcoli e astrazioni di una certa rilevanza.
D’altra parte, la scienza non si è fermata e in ogni campo di studio prosegue
la sua corsa, talvolta con rallentamenti, talvolta con cambi di rotta, ma in
sostanza non è immobile.
Lo stesso si può
dire, per esempio, dell’arte in senso stretto. Il Novecento, in particolare la
seconda metà, ha segnato un momento di svolta non da poco nella percezione
dell’oggetto artistico e del concetto stesso di artisticità. La fotografia
stessa ha contribuito a questo cambiamento, ma non è che un elemento di un
processo ben più ampio, che ha radici persino filosofiche. In molte opere
d’arte minimali e concettuali, ad esempio, siamo di fronte ad uno scambio tra
forma e pensiero che spesso pende a favore di quest’ultimo fattore, rendendo
incomprensibile ai più il risultato di quanto stiano osservando nella realtà.
Nell’Ottocento,
sulla scia della teoria evoluzionista, si formò quasi il dogma dell’eterno
progresso: l’umanità era destinata ad evolversi senza fine verso un benessere
sempre maggiore. Un pensiero del genere, sostenuto oggi, farebbe ridere
chiunque, eppure una tale assurdità ha fecondato decenni di storia,
influenzando e offrendo l’alibi anche alla supremazia razziale. Posto che tale
pensiero era appunto frutto di un razionalismo divenuto ormai dogmatico (e la
storia lo dimostra, ragion per cui non ci soffermeremo), non si può negare che
nella storia dell’umanità vi siano stati dei cambiamenti tali da aver mutato
anche drasticamente il pensiero, lo stile di vita, la cultura e la socialità.
Sarebbe però un errore confondere l’evoluzione tecnica con l’evoluzione umana:
d’altra parte è sotto gli occhi di tutti come l’eccezionale tecnica raggiunta
in campo militare non abbia significato altro che un miglioramento in termini
di capacità di sterminio e di minaccia.
In casi meno
drastici, però, troviamo innovazioni tecniche che hanno permesso all’uomo di
rapportarsi in maniera diversa con se stesso e con l’esterno (si pensi
all’invenzione dell’automobile e alla riduzione dei tempi di spostamento). Se
tuttavia si prova a riflettere meglio, non è la tecnica ad aver permesso
all’uomo di cambiare: è pur sempre il pensiero umano che, avendo individuato
una soluzione per migliorare la propria esistenza, perfeziona o inventa uno
strumento che gli renda più facile l’esercizio di ciò che il suo pensiero aveva
concepito.
Tutto questo
porta ad una conclusione: nell’uomo non è la tecnica (l’“oggetto materiale”) a
fare la differenza, bensì il processo cognitivo (il “soggetto pensante”) che
sta alle origini della sua creazione. Bisogna però uscire dall’idea di
evoluzione così come l’abbiamo ereditata dall’Ottocento: nel caso dell’arte,
per esempio, bisogna ritornare ad apprezzarla per ciò che è e non più solo per
ciò che in una prospettiva storica rappresenta. Altrimenti il rischio è quello
di un disinteresse verso la ricerca stessa di nuove formule. L’Uomo non evolve,
bensì indaga la propria esistenza concentrandosi a seconda del momento su un
preciso aspetto del pensiero. L’Uomo in quanto tale, per dirla in altri
termini, non può concepire nulla più di quanto la sua costituzione esistenziale
gli consenta. Ora, l’unica vera domanda, ancora insoluta, è quale sia questo
limite e se vi sia un modo per oltrepassarlo.
Rimanendo però
al nostro argomento, ciò che la trasmissione del sapere scritto (e ormai
multimediatico) ha permesso è la conservazione – che col tempo diviene “Storia”
– dei processi di pensiero applicati dall’Uomo alla realtà. Questo vantaggio
potrebbe però essere solo in parte tale: da un lato, infatti, la preservazione
di informazioni del passato ci consente di adattare il presente in modo tale da
evitare non solo gli errori, ma anche la ripetizione di processi di pensiero
già perseguiti. Dall’altro, proprio per queste ragioni, la conservazione del sapere
odierno, che ha caratteristiche persino ossessive e maniacali, comporta una
stasi nell’elaborazione di ulteriori processi di pensiero.
L’idea generale
sembra essere che tutto ciò che qualcuno possa pensare sia già stato concepito
e realizzato da qualcun altro, che sia nel presente o migliaia di anni
addietro. L’idea generale è che non sia più possibile sbagliare come genere
umano e che qualunque prospettiva coraggiosa sia automaticamente da marchiare
come pericolosa. Ciò ha contribuito a provocare, tra le altre cose, una
tendenza all’ipercorrettismo che ormai ha il sapore del ridicolo.
L’umanità, oggi,
può apprendere dal passato ad ogni generazione (e non solo dal passato recente),
ma, in definitiva, quella stessa umanità si rinnova ogni giorno e tutto ciò che
impara al contempo lo disimpara. L’umanità è una coscienza che, per fasi, deve
fare esperienza da sé del mondo, anche ripetendosi, purché l’esistenza sia
vissuta indagando tutte quelle vie che possano farle comprendere i propri
confini all’interno dell’Universo. La vera necessità, al massimo, è imparare a
riconoscere quelle vie che conducano alla conoscenza e non all’autodistruzione.



Commenti
Posta un commento
Grazie per aver visitato "La Voce d'Argento"! Condividi il tuo pensiero o lascia un commento: ogni opinione è importante e arricchisce la conversazione. Ti ricordo di rispettare le opinioni altrui e di evitare linguaggi inappropriati: i commenti sono moderati per garantire un ambiente costruttivo e piacevole. Buona lettura e grazie per il tuo contributo!